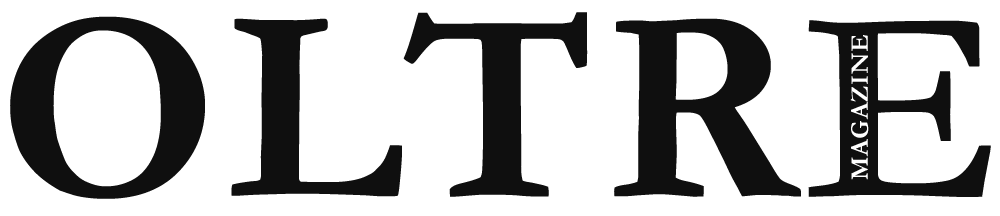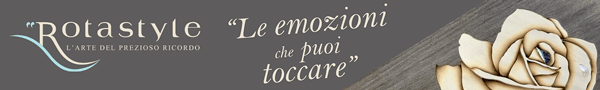La scomparsa di Whitney Houston
Se un usignolo muore nel freddo

Una bellezza selvatica, eppure elegante, pulita, vellutata; seducente tanto da fare quasi male e, tuttavia, quasi innocente. Una artista eccezionale, morbida e potente soprano interprete di canzoni senza tempo. Una sequenza armonica che non vorresti mai finisse di intonare musica melodica, soul e gospel accomunati da un unico, inconfondibile, limpido e ampio spettro acustico in grado di impreziosire ogni brano.
Souvenir acustici di fine anni ’80. Piccoli, importanti segnalibri di vita. Per me, esigente orecchio d’ascolto del blues e del pop d’altri tempi, ma anche attratto da performance melodiche di voci femminili, e occhio arrendevole ai contagi di bellezze dalle sfumature particolari, Whitney Houston, dal punto di vista dell’immagine riflessa dai media e dell’inseguirsi delle note lunghe regalate dall’hi-fi, non era soltanto una bravissima cantante, era semplicemente una donna perfetta. Era la fantasia, la favola, l’usignolo, la pantera. Piccoli momenti fugaci di giochi e di pensieri che, ogni tanto, anche gli uomini concedono a se stessi quando incrociano eccezionali e seducenti artiste e, di quelle immagini, ne fanno adulti miti.
Aveva trafitto definitivamente la mia fantasia e quella di almeno altri 42 milioni di persone quando, con una intensità travolgente, dalla magia contagiosa dello schermo indirizzava “I Will Always Love You” alla propria guardia del corpo, quel Kevin Costner fortunata spalla che, nel silenzio della sala, un poco invidiai; e non fui il solo. Inutile negare che quelle immagini sono segnate nel bagaglio della mia reminiscenza e che a quel film sono riconoscente. Mai avrei avuto altro modo per avvicinarmi di più ad un infantile, emancipato sogno fugace.
Whitney Houston, la voce, la stella, si è spenta nell’acqua di una stupida vasca da bagno dopo un percorso di vita travagliato e intimamente sofferto. Mi pare un terribile spreco. Avevo perso tracce della sua vita: non i piccoli ricordi, non alcune sequenze di accordi. Inevitabilmente, io che amo la vita e che mal digerisco certe morti premature, ci sono rimasto molto male e istintivamente ho sentito gridare da dentro: “perché?”.

Ora di lei si ripercorreranno storia e carriera, il grafico del successo troverà spazio in fantasiosi assi cartesiani, torneranno a vendersi alcuni dischi a San Valentino, i rotocalchi avranno di che scrivere per un po’, mentre i colleghi già la piangono davvero. Loro e forse soltanto loro, gli artisti, conoscono il misterioso percorso che porta al baratro carriere luminose che paiono destinate a brillare per sempre. È un sibillino intreccio di pesi troppo gravosi: paure, fragilità, il frenetico roteare di confronti, di premi e di aeroplani, di obblighi mondani e di sofferti amori, il ticchettio di metronomi che scandiscono il tempo che passa, quasi fosse più importante, lassù nell’Olimpo delle stelle.
Forse i nostri miti sono anch’essi anime normali e come noi, sono talvolta gracili, sensibili, ostaggi di se stessi, prigionieri di sogni assopiti, storditi, incanalati per altre seducenti strade non agevoli per tutti. Forse sono un cuore in mezzo al petto come tanti, sebbene custodito da un corpo bellissimo che sorride a un esigente pianeta di nome “successo”. Pianeta magico, irraggiungibile per noi, carne ed ossa della stessa qualità, ma con qualche ottava in meno per cantare e con ancor meno fascino su cui contare, a noi proibito, ignoto mondo, impalpabile illusione altrove.
Forse i nostri miti sono anch’essi anime normali e come noi, sono talvolta gracili, sensibili, ostaggi di se stessi, prigionieri di sogni assopiti, storditi, incanalati per altre seducenti strade non agevoli per tutti. Forse sono un cuore in mezzo al petto come tanti, sebbene custodito da un corpo bellissimo che sorride a un esigente pianeta di nome “successo”. Pianeta magico, irraggiungibile per noi, carne ed ossa della stessa qualità, ma con qualche ottava in meno per cantare e con ancor meno fascino su cui contare, a noi proibito, ignoto mondo, impalpabile illusione altrove.
Whitney Houston aveva iniziato a sgretolarsi da tempo, unica padrona del proprio intimo perché. L’Olimpo delle stelle non è ingrato e di lei rimane l’indelebile segno generosamente impresso in digitale per sempre e per tutti noi. Ogni volta che un pollice premerà un telecomando, immortalata nel suo momento di maggior splendore, tornerà a interpretare la migliore parte di sé: bellissima per la sua guardia del corpo e per noi, umani sognatori con un cuore nei ricordi e l’altro nella quotidianità. Si parla spesso male della tecnologia, ma molte volte è una gran bella comodità. Mi accingo, per dare zucchero al mio cuore amareggiato, a cercare un brano che mi piace, “Bridge over Trouble Water”, cantato in coppia con Cece Winans, altra ugola di colore. È la cover di una celeberrima ballata di Paul Simon interpretata insieme ad Art Garfunkel nel 1970. È il miglior modo per rendere tributo a un mito: accomunarne quattro. Fatelo anche voi, è un consiglio spassionato.
Buon viaggio, Whitney!