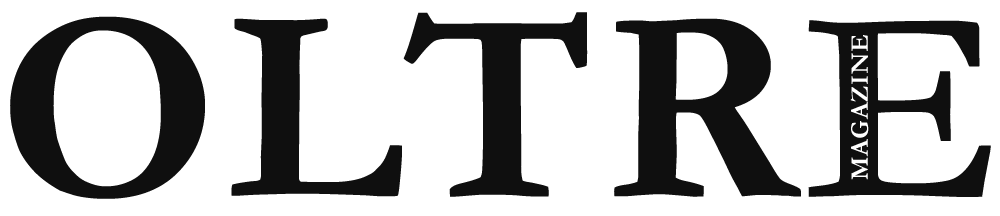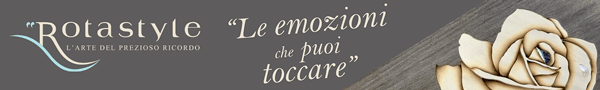2003, ANNO DEL DISABILE RIFLESSIONI & REAL TV

Sono un disabile, paralizzato dal 1986, caduto vittima di un umile attentato nostrano; un banale incidente stradale non premeditato. Da allora vivo piccolo, seduto sulla mia sedia a rotelle, vivo, guardo, medito, poi proferisco. Quest'anno 2003, da chissà chi è stato proclamato "anno del disabile". Invero, nel frattempo per me nulla è cambiato, ma ora che l'anno è quasi scaduto, mi si conceda una velata riflessione, ma più avanti, dopo aver descritto un luogo quasi sconosciuto, un centro specializzato dove scienza e sofferenza fanno rima con silente penitenza. L'ospedale, l'unità spinale, complesso di moderni elementi articolati e fabbricati in faccia al mare. È lì che sbarcano gli occhi stralunati dei feriti, dei freschi sopravvissuti martoriati da questa nostra feroce, sanguinosa guerra mai dichiarata. Guerra né persa e né vinta, e meno che mai finita. Sono occhi di ragazzi sbigottiti e spaventati, appesi ai loro colli spezzati nello schianto di un momento; spine dorsali imbullonate da un chirurgo abile, ma impotente a riparare il guasto permanente. Occhi grandi, rossi e lucidi, a ispezionarsi le braccia, le mani, le gambe che non si muovono più; appendici ciondolanti di corpi destinati ad una vita futura talmente dura ed esigente che a me, che tanta ne ho vissuta finora, il resuscitarla per poi descriverla mette angoscia, tristezza e paura.
Nell'unità spinale ho incontrato un'altra volta quegli occhi, gli stessi che avevo diciassette eterni anni or sono, in altro luogo ed altro tempo, così simili in quel momento. Li ho rivisti tutti intorno a me, forse ormai abituato a come sono adesso, o forse dimentico di com'ero quando correvo e saltellavo agile e pimpante. Ho incrociato nuovamente quegli sguardi laceri, spersi e sconfitti, là, nel girone degli sventurati, durante un recente, breve soggiorno di cura in quell'ospedale; moderna clinica specializzata, elegante ed efficiente, esposta al sole e al vento della Riviera di Ponente. Là ho sofferto per loro, per i nostri feriti senz'arma né divisa. Gente qualunque, gente innocente estirpata alla vita da un severo destino; figli e padri, donne, mariti, corpi interrotti, per i quali molto si può fare per recuperare poco o quasi niente.
Essi sono gli invalidi, i disabili motori, i diversamente abili, sono le vittime degli incidenti, quasi tutti stradali. Non cammineranno più, ma costose sedie a rotelle e ausili tecnologici sempre più perfezionati permetteranno loro di sopravvivere decentemente, di tornare a riagguantare, con tempo e tenacia, l'orgoglio di essere presenti tra la gente "normale", spesso colta di sorpresa nello scoprire che esistono; più piccoli e seduti, ma a volte persino belli, allegri, spiritosi, sebbene diroccati, disillusi e rassegnati. Tra quelle mura, tanto linde e profumate quanto intrise di angoscia latente, io disabile ormai quasi cinquantenne, ho guardato, meditato, e adesso proferisco.
In codesto anno del Signore 2003, anno del disa-
bile ben pubblicizzato, molte sono state le trasmissioni intellettuali in prima serata che hanno infiammato le televisioni, ma nessuna si è soffermata sulla nostra guerra italiana, ininterrotta e dimenticata. Ho seguito i dibattiti di una politica in pugnace e strepitante battaglia quasi come se la guerra di liberazione fosse là dall'essere finita, e poi la promessa di una guerra preventiva puntualmente mantenuta, quindi menzogne cantate per vere su temibili armi di distruzione di massa, infine, inevitabile e spettacolare, la morte in diretta. Morte a migliaia nel deserto straniero, poi le trasmissioni ogni sera. Gli esperti, i cialtroni, i convinti e i contrari a riempirci i canali, i cervelli e non soltanto quelli. Quella guerra è finita, ma si muore di più. Muoiono i nostri eroi, in terra straniera; non è certo una gran bella cosa, ma si sapeva, prima o poi sarebbe dovuto accadere, forse non si sarebbe dovuti andare, non così in fretta, ma questa è soltanto una mia idea; una idea soltanto mia? Nuovi dibattiti, forti emozioni, piange il Presidente, piange in diretta, l'Italia è in lutto, funerali a mezz'asta, gloria ed orgoglio per la Nazione. Si dice che era giusto andare a morire, di certo è così, parola di Televisione. C'è chi dice di no e chi invece di sì, altra carne fresca per la giostra dell'audience e per la trasmissione.
Io mi unisco al cordoglio che attanaglia la Nazione, ma nel frattempo ascolto la gente. Ascoltavo i pensieri in quell'ospedale, pensieri dispersi di innocui civili iellati e di infermieri abituati a leccare, con sorrisi e poche parole scherzose, le ferite più dure da rimarginare.
Il 2003 anno del disabile volge al tramonto e, nel frattempo, non una televisione, non una trasmissione né tanto meno una serie dedicata davvero al problema, né in prima, né in seconda serata. Peccato, si è perduta l'occasione di non doversi inventare granché per strappare emozione, per catturare interesse e, finalmente, per realizzare al contempo buona informazione. Nei giorni di festa muoiono in troppi, estirpati alla vita da un sorpasso azzardato o da un tamponamento, e molti di più sono i feriti, troppe volte non meglio specificati. È la guerra di strada; l'incidente è in agguato ad ogni istante, vale per tutti, indistintamente, si sa, ma stranamente quasi si ignora, mentre la pubblicità bombarda la mente con nuovi modelli di macchina, grigia, aggressiva, superdotata, sempre più veloce, sempre più potente. Mentre ero là, nell'ospedale, mi chiedevo "perché?". Perché le telecamere non entrano tra queste mura, in punta dei piedi, e senza ipocrisia né spettacolarità, ma con rispetto e pudore, intervistano, chiedono e inquadrano gli occhi, le mani, le braccia cadenti? Fa così impressione la verità? Forse non è abbastanza intelligente informare la gente su cosa succede nelle nostre città? È così complesso comunicare ai ragazzi quanto vale la vita e invitarli a mollare il piede dall'acceleratore, e poi magari poter raccontare che se succede ugualmente qualcosa di brutto bisogna sperare e non è mai finita? Ogni esistenza spezzata e seduta su una sedia a rotelle è una storia breve quanto infinita, è scuola di vita che vale la pena di essere raccontata, con semplicità, senza troppo rumore, con attenzione e discrezione, così che un'altra persona possa sapere, capire, imparare che non vale davvero la pena di rischiare la nostra splendida, unica, irripetibile vivacità, destinata comunque ad affievolirsi, ma secondo natura, senza affrettare la sofferenza, ma un po' più in là.
Non fanno sconti i telegiornali quando mostrano brandelli di corpi straziati, purché distanti, almeno mediorientali. Non se ne può più di programmi sanitari che trattano le diete dimagranti e le rughe permanenti delle pelli esposte al sole come se fossero il vero male della nostra società. Si fa spettacolo in prima serata con disgrazie estrapolate da filmati amatoriali, accuratamente statunitensi, mai nazionali. La gente intelligente è pronta ad altro. Ha fame di informazione semplice, di una real TV meno divertente, forse un po' dura da gustare, ma reale per davvero e di grande utilità.
L'anno del disabile lentamente se ne va. Restano sconosciute isole infelici le tante unità spinali con le loro storie vere, le nostre verità, ma non solo. Scivolano adagio verso il nuovo giorno le tante case di cura dove i figli di un Dio minore, emarginati e fuori dal gioco, strappano ugualmente un alito e un sorriso ad un destino che ha relegato tante vite in condizioni di inferiorità. Lì sono i vecchi ma non troppo, non ancora, sono i bambini imperfetti, sono esseri normali aggrediti da malattie perverse, persone che sono, che siamo, un po' diverse. Questo è un universo di anime, è il variegato popolo denominato di "disabili", una massa ben presente, sofferente sì, ma spesso ricca di incredibili risorse, una popolazione di tanto in tanto appena raccontata in qualche teatrino che solleva il sipario e trasforma un caso isolato in una struggente, sapiente, fuggente, memorabile puntata.
Chiunque venisse a contatto con tante di codeste realtà non potrebbe che scegliere tra due strade: premere il pulsante e cambiare canale, oppure andare oltre, voler capire, pretendere, per poi rallentare, partire, andare e condividere. È tempo di fare cultura, di informare la gente che un brutto incidente può accadere. È tempo di insegnare a evitare le trappole più comuni e diffuse, che in un solo istante spezzano quella schiena che la natura ci ha dato pur salda e resistente. È tempo di raccontare che la vita la si può giocare finché non è finita, sebbene feriti, amputati o paralizzati. È tempo di educazione, di chi non si farà mai niente e di chi ci cascherà, perché un reinserimento richiede preparazione e sapienza su come livellare ogni preconcetto, ogni diversità.
L'anno del disabile 2003 resta una bella voce di una sgangherata e inutile pubblicità. L'anno prossimo non lo sarà più, ma non per questo qualche disabile ne guarirà. Altre guerre molto interessanti, morti violente e spettacolari, riempiranno le rubriche ed i telegiornali, ed un ragazzo con la macchina turbo uscirà di strada e si aggiungerà a noi disabili, popolo a rotelle, prodotto folle, forse un po' evitabile, sotterraneo, diffuso e per certi versi incomprensibile, di questa nostra schizofrenica civiltà.
È tempo di osare e di farlo, gli occhi tristi dei nostri figli e dei padri, dei nostri feriti quotidiani per attentato, per caduta sul lavoro o per scivolone dal motorino, non sono meno importanti degli sguardi sperduti dei bambini iracheni. Forse occorre troppo coraggio per raccontare con un rispettoso, realistico fraseggio, i rischi cui potrebbe incorrere chi, ogni giorno, esce di casa, sano e vigoroso immortale occidentale, immettendosi nel terroristico automobilistico circuito perverso che lo attende e reclama ogni anno vittime a migliaia?
L'unità spinale, con i suoi camici bianchi a consolare occhi rossi di stupefatta disperazione, è sempre là, in faccia al mare, ignorato serbatoio di informazione che potrebbe contribuire a salvare alcune schiene, alcune vite. In quale altro anno se ne parlerà?