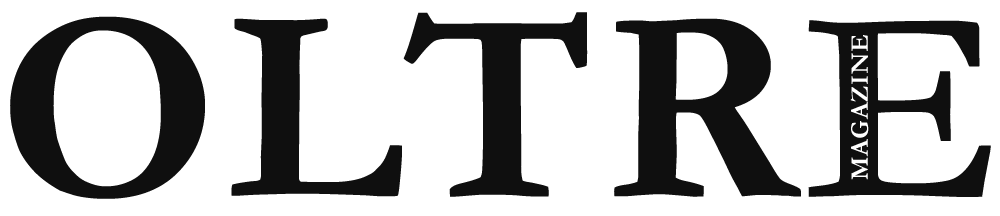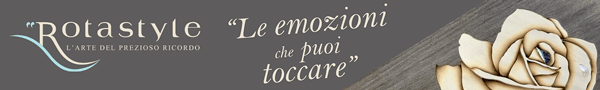Muore un bambino

C'è anche, per la verità, chi sostiene che bisognerebbe recuperare la saggezza pagana e prepararsi alla morte dei figli come fece il filosofo Anassagora che, alla morte del figlioletto, non pianse e mantenne la sua dignità proprio perché per tutta la vita si era preparato a questo evento. Ma è una via che non trova molto seguito tra i genitori che perdono un figlio piccolo i quali cercano a tutti costi di negare la morte del figlio nei mille modi in cui ciò è possibile, credendo che il figlio morto in realtà li aspetta sotto un'altra forma di vita nell'aldilà o che vive ancora come prima ma in un'altra dimensione con la quale è possibile comunicare.
Nessuna di questa difese sembra funzionare oggi, se è vero che quando muore un bambino tutti vanno in crisi e tendono a pensare di essere in presenza del male assoluto, un male senza rimedio che fa perdere la sicurezza di vivere. Se anche un bambino può morire, infatti, di cosa si può più essere certi? Quando la vita del bambino era ancora una vita incompiuta gli adulti non le attribuivano un grande valore e potevano viverla, poi l'infanzia è diventata la fase più importante della vita e ogni bambino ha acquistato un valore immenso, tanto da dover lottare strenuamente per salvarlo da una morte precoce, dall'avere difficoltà a sostituirlo con un altro bambino e dal dover farlo sopravvivere da qualche altra parte. Così gli adulti si sono identificati con i bambini e ogni bambino è diventato parte del sé degli adulti: si spiega così il fatto che di fronte alla morte di un bambino la maggior parte delle persone oggi si sente come di fronte alla morte del "proprio" bambino (proprio sia nel senso del bambino che vorrebbe ancora essere, sia dei bambini in carne ed ossa che hanno eventualmente messo al mondo).
Ma quando muore un bambino non muore il proprio bambino, muore un bambino "altro" sia dal bambino che ciascuno di noi vuole essere che dai bambini che ciascuno di noi ha generato. È quello che intravedono coloro che alla morte di un bambino dicono: "Non è per me che piango, ma per il mio bambino che non potrà più vivere". Ecco, questo pianto, il pianto per il bambino morto e non per il proprio bambino che si sente minacciato di morte, è il pianto che potrebbe consentire di affrontare la morte di un bambino sfuggendo alle alternative talvolta altrettanto "impossibili" di svalutarlo per abbandonarlo al suo destino, di sostituirlo con un altro bambino o di doverlo far vivere altrove perché è impossibile far morire qualcosa di "proprio".
Ma perché molti di fronte ad un bambino morto non riescono a far prevalere il piangere per l'altro, il perpatire, (Francesco Campione, Perpatire, saggio sull'altruismo, Armando Editore, Roma, 2006) sul piangere per sé, ed hanno più compassione per la minaccia che la morte del bambino porta al "proprio" bambino piuttosto che per il bambino "altro" che non potrà più vivere?
La ragione sembra abbastanza semplice: la morte del bambino "tocca" il proprio bambino e traumatizza. La sofferenza che ne deriva a chi è toccato fa dimenticare che non tutto ciò che tocca e fa soffrire ci appartiene. L'uomo ha la possibilità, soffrendo per un bambino morto, di ospitare in sé ("sentire in sé") la sofferenza per questa morte non impadronendosene come di una propria sofferenza, se di fronte alla sofferenza è in grado di non pensare solo a sé, cioè di essere sufficientemente uscito dall'egocentrismo infantile da non scambiare la morte di un bambino con la morte del "proprio" bambino. In sintesi alla morte di un bambino solo chi non è più un bambino riesce a commuoversi umanamente senza esserne distrutto come se avesse perso il proprio bambino.