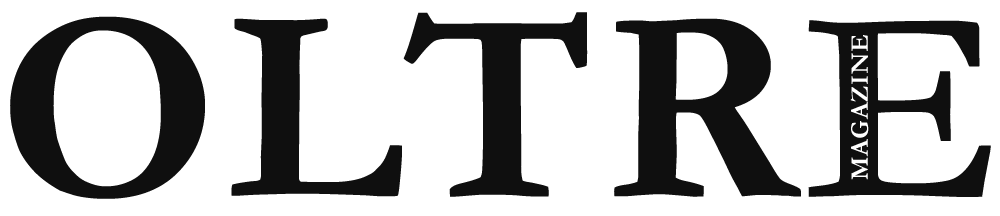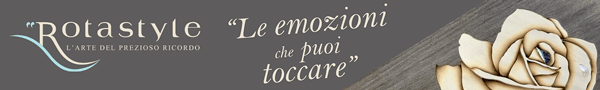Il Don Carlo di Verdi alla Scala
Io morrò, ma lieto in core

Don Carlo è forse fra i capolavori verdiani quello che ha impiegato più tempo per essere riconosciuto come tale; ora è fra quelli che ad ogni nuovo ascolto “crescono” e rivelano nuovi aspetti e nuove qualità. Già abbiamo avuto occasione in passato di soffermarci in particolare su una scena dell’opera, la celebre aria in cui il sovrano spagnolo Filippo II paragona il palazzo dell’Escorial ad un immane sepolcro in cui solo dopo la morte troverà pace. Ma il discorso deve essere esteso prendendo in considerazione il complesso dell’opera, nella quale la presenza del pensiero della morte (al di là delle morti che avvengono in scena) è davvero profonda e pervasiva, tanto da potersi considerare un suo vero e proprio carattere di fondo. Per farcene un’idea, qualche cenno sarà sufficiente. Basterà anzitutto ricordare come inizia l’opera, nella sua versione più diffusa, quella in soli quattro atti.
“Chiostro del Convento di San Giusto. A destra, una cappella illuminata. Vi si vede, attraverso ad un cancello dorato, la tomba di Carlo V. […] Giardino con alti cipressi. È l’alba. Sulla scena un Frate, prostrato innanzi alla tomba, prega sottovoce”. Così recita la prima didascalia, ponendo ad emblema iniziale del dramma il sepolcro del più grande imperatore dei tempi moderni, colui sul cui regno non tramontava mai il sole; e la stessa immagine ne sarà il sigillo finale, quando alla conclusione dell’opera una enigmatica, spettrale figura di frate (con la voce del defunto sovrano) proprio in quel sepolcro trascinerà il nipote, l’infelice infante don Carlo. E la prima voce che udiamo è quella di un coro di frati che sussurra queste parole: “Carlo, il sommo imperatore/Non è più che muta polvere”, quasi a porre fin dall’inizio quello che sarà un tema dominante.
È una vera e propria pulsione di morte quella che pervade l’infelice don Carlo in vari decisivi momenti del dramma, per esempio quando è posto di fronte al nodo dell’amore impossibile fra lui e l’amata Elisabetta, divenuta sventuratamente sua matrigna: “Alla mia tomba, al sonno dell’avel/Sottrarmi perché vuoi, spietato ciel!” è il suo grido, e “Sotto il mio piè si dischiuda la terra, [...]/Io t’amo, Elisabetta...!”. “Il mondo è a me sparito!” è il suo augurio, nell’assoluta impossibilità di un’azione risolutiva. Proprio all’azione, quella politica però, a favore delle Fiandre oppresse crudelmente dal padre Filippo II, aveva pensato di rivolgersi l’Infante insieme al fraterno amico Rodrigo, marchese di Posa: “Giuriamo insiem di vivere/E di morire insieme”. Ma Rodrigo precederà nella morte l’amico, spirando tra le sue braccia colpito per volontà del sovrano e dell’Inquisizione. Varie volte i momenti che precedono la fine di un personaggio fecero intonare a Verdi la musica più intensa e toccante: raramente però commovente come gli stupendi ariosi di “Posa”, di “Per me giunto è il dì supremo” e di “Io morrò, ma lieto in core”: “E se non piangi, di che pianger suoli?” si potrebbe chiedere, con Dante, all’improbabile ascoltatore che rimanesse insensibile…

Né manca, da parte dell’imperatore Filippo, la convinta rivendicazione della morte come strumento di regno: “Col sangue sol potei la pace aver del mondo […] La morte in questa man ha un avvenir fecondo”. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma è meglio rinviare il lettore all’incontro diretto con questo capolavoro verdiano, solo da pochi decenni definitivamente rivalutato.
Una occasione di ascolto è stata offerta dal Teatro alla Scala, che ha inaugurato la stagione 2008/2009 con un nuovo allestimento dell’opera, a vari anni di distanza dal precedente, diretto da Riccardo Muti, che vide l’ultima, controversa presenza di Luciano Pavarotti sul palcoscenico milanese. La versione dell’opera oggi presentata è quella in quattro atti, cui facevamo riferimento sopra. Apprezzabile, come sempre di elevata qualità, la direzione di Daniele Gatti, benché qualche ascoltatore abbia mosso rilievi su alcune scelte di tempi e benché sia diffusa l’idea che le eccellenti doti del Maestro risaltino meglio nel repertorio tedesco, wagneriano soprattutto. Senza infamia e senza lode, per essere sintetici, l’allestimento scenico e la regia. Nella compagnia di canto si sono distinti in particolare il basso Ferruccio Furlanetto nel ruolo di Filippo II e la sempre brava Fiorenza Cedolins in quello della Regina; un po’ in secondo piano gli altri, Dalibor Jenis, Dolora Zajick e Anatoli Kotscherga (rispettivamente Posa, Eboli e l’Inquisitore), nonché il tenore Stuart Neill nel ruolo di Carlo, la cui presenza scenica oltretutto non può non essere compromessa dalle sue veramente madornali dimensioni corporali.
Una vicenda abbastanza tipica del sempre un po’ convulso (e anche per questo divertentissimo) mondo operistico ha caratterizzato la “prima” di Sant’Ambrogio e i giorni immediatamente precedenti: il tenore en titre, il bravo Giuseppe Filianoti, nelle prove incontra però secondo il Direttore e i responsabili del teatro difficoltà tali da consigliarne la sostituzione; alla reazione sdegnata del sostituito fa seguito (secondo la testimonianza dei più esperti loggionisti presenti al fatto), la sera della prima, la veemente contestazione dell’intero spettacolo da parte di un piccolo ma tonitruante manipolo di suoi sostenitori. Alle loro urla tremavano i pavimenti della galleria...
Un tenore cambiato: non è mica morto nessuno, si potrebbe dire; ma nel mondo dell’Opera, e in particolare a Milano e soprattutto a Sant’Ambrogio, basta anche meno per scatenare un cataclisma!