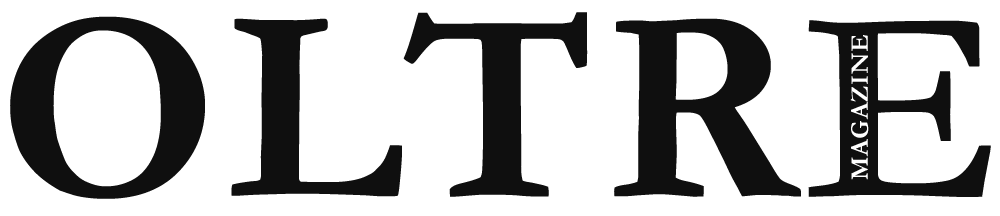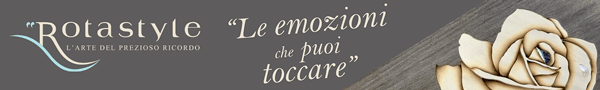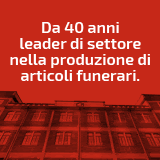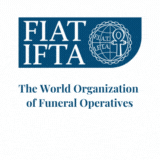El Cementerio Central a Montevideo
Un giardino di marmi italiani

Il Cimitero Centrale di Montevideo, presentandosi come testimone di una numerosa compagine di scultori ed architetti italiani nonché specchio del gusto dell'oligarchia cittadina, è uno dei luoghi maggiormente segnati dalla cultura italiana.
Una volta giunto sull'altra sponda dell'Oceano e dopo essersi creato una posizione economica, il primo pensiero dell'emigrante ottocentesco è quello di ricostruire le abitudini e gli status della terra d'origine. E tra le priorità vi è senza dubbio l'acquisto di una tomba di famiglia, spesso di manifattura europea, che riportasse alla mente le immagini di quei cimiteri monumentali che avevano già preso piede in Italia a partire dall'editto di Saint-Cloud (1804). Quest'ultimo è un meccanismo sociale che vale per tutta l'area del Sud America; ne è la prova un passaggio del fortunato Don Casmurro (1899) dello scrittore brasiliano Machado de Assis (1839-1908). L'autore narra la vicenda di un uomo di classe media, Pádua, che non appena vinta la lotteria pensa al modo di investire il denaro: "La prima idea [...] fu di comperare un cavallo, un gioiello di brillanti per la moglie, una tomba di famiglia, far venire dall'Europa alcuni uccelli, …".
È proprio grazie a questo processo che un folto numero di scultori e laboratori specializzati hanno potuto sostenersi per anni con gli incarichi provenienti dai cimiteri sudamericani. Nel caso dell'Uruguay, la necropoli più antica è il Cimitero Centrale che nei progetti risale al 1838 e che con i suoi marmi risulta essere il primo monumento tout court dell'Uruguay. In realtà esisteva già un cimitero in epoca coloniale - se ne hanno testimonianze a partire dal 1808 - situato all'incrocio delle attuali calle Durazno e Andes; poi nel 1829 il piano regolatore della città esigette l'eliminazione di questo cimitero e l'annessione del nucleo più antico della città - la "ciudad vieja" - alla parte "nueva"; già dal 1835 si fece perciò impellente la creazione di un nuovo luogo deputato alle sepolture, che per lungaggini burocratiche e incertezze progettuali venne benedetto solennemente nel 1863.


Le opere, subito siglate col proprio nome, erano spesso copie di modelli già proposti con successo nei cimiteri italiani o che ad essi si ispiravano, come le tombe Deicas-Heres (1886), Alvarez (1886), Chucarro (1884), Bonifaz (1888), Costa (1890), Escalada (1891), Martinez (1893c.), che devono le proprie invenzioni iconografiche ad Agusto Rivalta, Cesare Faggioni, Federico Fabiani e molti altri. Il picco assoluto degli acquisti azzariniani è però senza dubbio il Minatore di Enrico Butti. La scultura che, nel 1888 vinse solamente il secondo premio al concorso Principe Umberto dell'Accademia di Brera - nonostante l'ottima modellazione - a causa della sua sfacciata denuncia sociale, orna oggi la tomba di Juan Nicola (1888c.). Purtroppo l'iter del marmo è scarsamente ricostruibile; grazie agli studi di Flavio Fergonzi è noto però che fu direttamente Giovanni Azzarini a prendere contatto con Butti, ma vista la distanza stilistica con le opere che ha procurato imperterrito per i cimiteri montevideani, non è da escludere che in questo caso abbia operato sotto esplicita richiesta dei committenti.
A parte qualche presenza di scultori lombardi, le due maggiori aree di provenienza restano, per l'ovvia presenza di cave, quelle liguri e toscane. Da Carrara in particolare - oltre a Giuseppe Livi - giungono a Montevideo Carlo Niccoli e Giovanni Del Vecchio. Al primo si deve la monumentale figura di vecchio della tomba di Tiburco Cachon il cui modello è conservato col titolo di Silenzio all'Accademia di Belle Arti di Carrara; mentre il secondo è l'autore della fortunatissima tomba Aramburu, la cui fusione viene però realizzata ancora in Italia.
Il merito di aver utilizzato per primo l'abbinamento di bronzo e granito, ma soprattutto di aver installato nella capitale una fonderia autonoma, spetta al napoletano Felice Morelli (1857-1922). Egli, sulla scorta del successo di Ettore Ximenes al cimitero della Recoleta a Buenos Aires, propone sul mercato cimiteriale uruguaiano le iconografie di possenti figure femminili accasciate su tombe in granito, spesso con atteggiamenti lascivi - un seno scoperto, lo sguardo estatico... - secondo l'immagine ricorrente del costante e flebile equilibrio tra Eros e Thanathos: un esempio su tutti la tomba Peirano.
L'attività del Central rallentò negli anni venti in favore del Buceo, il secondo cimitero monumentale della capitale che, sorto in un area leggermente periferica, non conosceva limiti spaziali e divenne il luogo delle commemorazioni moderne, lasciando al Central il ruolo di testimone delle origini della nazione.