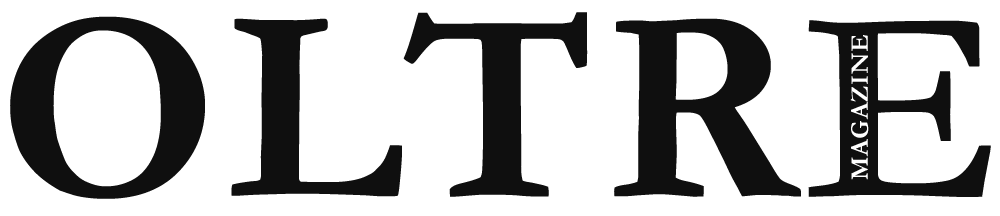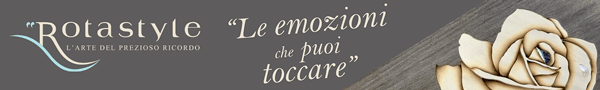Il dolore e le lacrime
Sofferenza interiore e lutto: il pianto è una valvola di sfogo necessaria per elaborare la perdita.
Quando ci colpisce all’improvviso per la morte di una persona a cui vogliamo bene, si abbatte su di noi come un vero e proprio shock che destabilizza la nostra vita e sconvolge la nostra serenità, magari acquisita con fatica nel corso degli anni. Un lutto improvviso è come un trauma: incomprensibile e incredibile. Per questo motivo, necessita di tempo e cure per essere elaborato e, dunque, reinserito nella trama dell’esistenza individuale, fornito di un qualche senso.
Siamo abituati ad associare fin da piccoli le lacrime e il pianto al dolore, fisico o emotivo che sia, e quindi, a maggior ragione, alla malattia e alla morte.
Nei film, nelle serie TV, nei cartoni animati, spesso quando vengono rappresentati i funerali vengono anche mostrate persone vestite di nero che, in lacrime, si asciugano gli occhi con un fazzoletto oppure si nascondono dietro grandi occhiali scuri. Eppure, a pensarci bene, il binomio dolore - lacrime non è affatto scontato, soprattutto per quanto riguarda le morti improvvise, a cui non c’è stato modo di potersi “abituare” gradualmente. Sappiamo che nell’antichità il momento del trapasso, fosse per vecchiaia, malattia o incidente, era molto più ritualizzato di quanto avviene nella società contemporanea in cui il dolore e la sofferenza sono fatti personali, da viversi nella propria privacy e con poche manifestazioni esterne.
Questo ha portato a un maggior approfondimento introspettivo del lutto e al nostro “pudore” di mostrare agli altri, soprattutto se sconosciuti, la portata della nostra sofferenza. Mentre, infatti, nell’antichità i parenti del morto mostravano i segni della disperazione al momento del funerale con grida, lamenti, pianti e lacrime ben visibili e addirittura assoldavano delle prefiche, il cui lavoro consisteva nel piangere e nel lamentarsi in presenza del cadavere, oggi spesso le persone trattengono il pianto, soprattutto in pubblico. Ma piangere senza ritegno, come fanno i bambini quando sono feriti o tristi, fa bene? La scienza ci dice di sì.
Scoppiare in lacrime (e già questa espressione ci fa capire che il pianto è un “rompere gli argini”) ha sull’individuo, che esperisce dentro di sé un tumulto di emozioni che lo sopraffanno, un effetto liberatorio. Piangendo, quindi, è come se noi aprissimo una sorta di “valvola di sfogo” per la nostra pressione emotiva interiore. Con le lacrime, con i singhiozzi e con i lamenti noi siamo in grado di ridurre lo stress di ciò che ci portiamo dentro. Se, al contrario, imbottigliamo la nostra sofferenza, ma anche la nostra rabbia, il nostro stress psicofisico non può che aumentare e rischiamo poi di “esplodere” chissà come e chissà quando. Il pianto, quindi, dà sollievo alla tensione emotiva e allevia il dolore stesso: ha un effetto calmante e stimola il rilascio di ossitocina e endorfine, che sono gli antidolorifici che il nostro organismo possiede naturalmente.
Strategie di fronteggiamento del dolore basate sulla “repressione” delle emozioni esperite si rivelano disfunzionali e disadattive, proprio perché non permettono all’individuo di alleviare il fardello emotivo di cui è gravato; sono anche correlate a disturbi e patologie di vario tipo, come elevata pressione sanguigna, problematiche a livello del sistema immunitario, disturbi cardiaci, disturbi del tono dell’umore e disturbi della sfera dell’ansia. Il pianto, inoltre, elicita risposte di compassione e di soccorso nelle persone che ci circondano, quindi è molto funzionale per ottenere conforto, sostegno e supporto (pensateci, i bambini piccoli piangono disperati quando vogliono ottenere qualcosa da un adulto). Tenersi tutto “dentro” non fa bene, né da bambini, né da adulti, ma è vero anche che non si piange “a comando” e alcune persone, per vari fattori che si intersecano tra loro, hanno più difficoltà di altre a “lasciarsi andare”, sia per quanto riguarda le emozioni positive, che per quanto riguarda quelle “negative”.
Ritornando al tema della mancanza di ritualizzazione della morte, si può dire che nella società occidentale contemporanea gli individui sono scoraggiati molto precocemente dal piangere (“sii forte”; “non piangere: le lacrime non servono a nulla”, ecc.), poiché le lacrime non sono percepite come una strategia attiva per cercare di cambiare la situazione negativa in cui ci dibattiamo, ma soltanto come una strategia passiva e inefficace, qualcosa che pertiene alla sfera della prima infanzia e che gradualmente deve essere abbandonata (“ormai sei un ometto/una donnina, non voglio più vederti piangere” ecc.) perché segno di “debolezza”. Questo è stato tanto più vero per gli uomini, considerati per lungo tempo meno “emotivi” delle donne, ma oggigiorno anche le bambine vengono educate a essere “forti”, dunque a non piangere; perciò, si viene ad assottigliare la differenza di genere culturalmente imposta.
Il pianto dopo la morte di una persona amata facilita, invece, il processo di lutto, che in questo modo viene elaborato meglio e più in fretta.
È, però, difficile sfogarsi attraverso il pianto quando la morte della persona cara ci coglie di sorpresa, all’improvviso, perché, come abbiamo detto, la morte in questo caso agisce da trauma e genera un forte senso di incredulità e irrealtà (“non è possibile”; “non può essere vero” ecc.).
Che fare allora? Bisogna dare (o darsi) tempo: la mente ne ha bisogno per assorbire la notizia infausta e cominciare a elaborarla. Il tempo delle lacrime, dello sfogo del dolore emotivo e di tutto quel caleidoscopio di sensazioni che ci portiamo dietro, arriverà dopo la fase dello shock.
è così che inizierà il processo di “guarigione” e il lutto potrà evolversi.Linda Savelli: dottoressa in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità e filosofa.